Il tratto lucano della Rocchetta San Antonio Lacedonia-Gioia del Colle attraversa la Basilicata costeggiando la valle del Bradano, tagliandola in due, girandole intorno per poi addentrarsi in Irpinia. Le stazioni non sono molte ma sono le più belle mai viste. Delle quattro stazioni incontrate solo San Nicola di Melfi non regge il confronto con le opere d’arte di Palazzo San Gervasio, Venosa e Lavello.
Il viaggio inizia al confine con la Puglia. La provincia di BAT nella sua estrema porzione occidentale. A pochi km dal paese appulo di Spinazzola.
Lascio la desolata statale Bradanica,direzione Palazzo San Gervasio e lí, tra orizzonti sterminati, il paese appare adagiato sul colle a dominare la pianura.
Appena prima dell’ abitato, una strada sterrata conduce, dopo un breve rettilineo, in un angolo di solitudine dove il tempo si fonde stranamente con il suo stesso riflesso di immutabilitá rendendo l’ambiente un eterno immodificabile dalla mano dell’uomo.

Lo stabile è un’opera d’arte dallo stile aristocratico settecentesco con infiltrazioni romantiche rese nostalgiche dal passare degli anni e il connubio con la natura circostante avvolge tutto in un emotivo abbraccio di colori.
Palazzo San Gervasio aveva un treno. Oggi non passa più. La linea è sospesa, forse dismessa. La natura non l’ha spogliata del suo antico fascino, al contrario l’ha consacrata in un ammaliante attimo di sacralità che si alimenta ad ogni sguardo rivolto.
La stazione è giù. Come tutti gli scali d’Italia. Conserva il suo equilibrio di partenze/arrivi lungo una via secondaria. Da un niente all’altro. Eppure di qui si partiva e si arrivava pure.


La bellezza di questa stazione è coinvolgente. Nei dintorni solo il rumore del vento. Sono solo, a Palazzo.
Gli interni della stazione sono chiusi e parte dei binari è ormai sepolta dalla vegetazione che col suo inesorabile e famelico istinto di voracità, ingurgita tutto.
Per chi giungeva dalla Puglia, la prima stazione lucana appariva immersa in una prateria di colori accesi di estati roventi.
Non c’è nessuno a Palazzo. La mia crociata lungo le strade ferrate lucane vive momenti di massima devozione alla sacralità del luogo, come un culto religioso. Prima di andare trovo l’angolo per immortalare Palazzo nella sua massima espressione di nobile decaduta e poi vado verso Venosa.

Lascio la statale Bradanica perché lo scalo di Venosa si trova più all’interno dal lato lucano della valle del Bradano. Dall’altro lato le Murge.
Il sole è accecante e i colori si alternano in sfumature giallo-azzurre e dopo qualche tornante lungo una specie di canyon il cui fondo è totalmente ricoperto di vegetazione, la stradina si allarga in uno spiazzale imprevisto.
La stazione di Venosa-Maschito è lí, silenziosa ma possente. Mantiene lo stile di Palazzo, nobile e nostalgica. Per metà divorata dalle piante.

Anche qui sono solo. Nessuna traccia di vissuti recenti, nessuna contaminazione di modernità. Venosa è ribelle, mantiene la sua seduttiva traccia di passato.
I binari si vedono a fatica e devo lottare con la vegetazione per poterla immortalare in foto.

Il treno si addentrava in Lucania mantenendosi distante dai monti ma oltrepassando in maniera trasversale la valle del Bradano, in un altopiano sterminato che apre le porte al Tavoliere più a nord.
Venosa è femmina. Il suo profilo colorato non è sepolto dall’erba rampicante. Al contrario essa ne viene accarezzata in un delicato ornamento.

Lascio Venosa nel suo angolo di vanto alla volta di Lavello raggiungendo la conclusione che la maggior parte della gente veda questi capolavori di architettura urbana come cattedrali nel deserto, giudicandoli per la loro inutilità o ancora, trasportando il discorso su binari politici, colpevoli ovunque per tali scempi.
Invece ancora una volta l’inclinazione romantica prende il sopravvento sulle dicerie popolari e sulla fredda chiusura mentale che non permette la visione quadrangolare degli orizzonti limitando la fantasia,privandosi di immaginazione. Sono belle così, con il loro carico decadente e infuturibile.
Lavello è lontanissima dalla sua stazione. Per trovarla devo scendere lungo una collina che la nasconde dall’altopiano in cui si trova il paese.
La stazione di Lavello-Rapolla è sopraffatta dalla natura. Potrebbe sembrare che si sia arresa all’inevitabile passare dei decenni invece sono convinto che la natura stia innalzando quello scudo tipico, già incontrato nelle stazioni delle linee precedenti, a difesa della memoria.

Gli interni sono inaccessibili e i binari sono ormai sepolti da una folta coltre di erbe, spine e arbusti attorcigliati su loro stessi.
Siamo nella parte più settentrionale di Lucania, al confine con Puglia e Campania. A nord il Tavoliere, ad ovest l’Irpinia. Sullo sfondo il Vulture.
I colori di Lavello sono accesi e la natura intorno crea un incendio di emozioni che solo i treni del passato potrebbero riflettere.

È ora di andare alla volta di San Nicola di Melfi, ultima fermata lucana prima dell’Irpinia.
Mi volto e Lavello scompare alle mie spalle silenziosa come mi era apparsa. Ritorno sulla statale ripercorrendo a ritroso le curve raggiungendo la Bradanica.

San Nicola di Melfi è diversa dalle stazioni precedenti. Essa è in piena zona industriale e nonostante non sia più attiva, ospita le manovre dei treni merci che raggiungono l’invaso della Fiat. Non ha uno stabile antico e non stimola la creatività come le precedenti Lavello,Venosa e Palazzo. Tuttavia sono al confine e l’immagine che mi si presenta è di evasiva libertá.

Non mi trattengo molto a San Nicola ma decido di imboccare la statale per il capoluogo lucano alla volta della linea Foggia-Potenza il cui tratto regionale inizia con la fermata di Leonessa, non distante da San Nicola. Ma questa è un’altra storia.

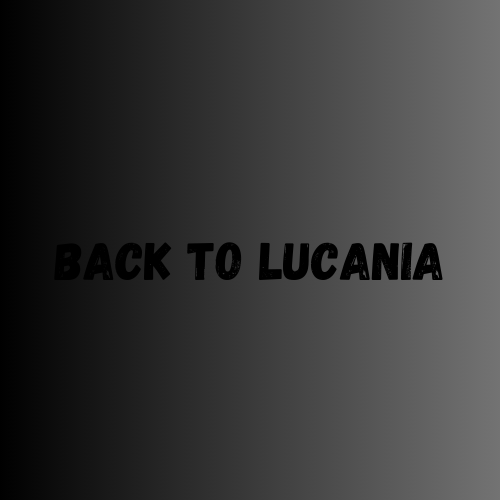
Lascia un commento